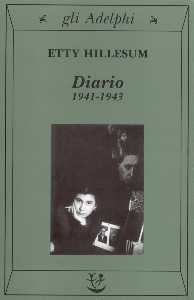
Diario (1941-1943)
di Hillesum Etty
Adelphi (collana Gli Adelphi), 1996
260 p., brossura, 12 ed.
Aforismi tratti da Diario 1941 – 1943
E se non potrò sopravvivere, allora si vedrà chi sono da come morirò.
Quel che viene è bene.
E. Hillesum, dal Diario
Di tutte le testimonianze sulle persecuzioni naziste a danno degli Ebrei, di tutte le storie di filo spinato, camini fumanti e umanità calpestata, quella di Etty Hillesum è la più lontana dall’ordinario – ammesso che simili racconti possano risultare “ordinari”, almeno nell’ambito di quello che ormai è un genere letterario. Il diario di Etty non racconta “per filo e per segno i maltrattamenti subiti” dalle vittime del nazismo, e Auschwitz, con il suo fiato mortifero, non è protagonista di queste pagine, ma resta un’ombra (seppure ineluttabile) sullo sfondo; l’autrice stessa afferma: “In futuro ci sarà chi pubblicherà tutti questi dettagli, e probabilmente sarà necessario per tramandare la storia di questo tempo nella sua compiutezza. Io non ne sento il bisogno.”. La storia che ci racconta Etty non è quella degli oppressi e degli aguzzini, ma quella della rinascita interiore di una giovane donna, il fiorire di una consapevolezza di sé tanto genuina e profonda da permetterle di scorgere il perseguitato dietro la maschera del persecutore, e riconoscere nella vittima la possibilità di emanciparsi dal proprio ruolo.
Quando comincia a tenere un diario, Etty ha ventisette anni e conduce una vita molto libera per il suo tempo: olandese, figlia della borghesia intellettuale ebraica, vive con il proprio compagno in un appartamento misto, dà lezioni private di Russo, legge Rilke, Dostoevskij, Jung; assapora la vita in tutti i suoi aspetti, e non si priva di amicizie e relazioni amorose. Da un punto di vista materiale e affettivo, Etty non manca di nulla; eppure si sente “un gomitolo aggrovigliato”, affetta da “costipazione spirituale”. Decide così di entrare in terapia presso lo studio di Julius Spier (“S.” nel diario), allievo di Jung e personalità carismatica ed eclettica, il quale la inizierà a un tipo di introspezione che, oltre a farle riconsiderare il suo rapporto con il prossimo e con se stessa, le farà scoprire un ‘luogo’ interiore in cui le sarà possibile raccogliersi, un riferimento concreto a cui potrà sempre tornare per ritrovarsi: “io riposo in me stessa. E questo «me stessa», la parte più profonda e ricca di me in cui riposo, io la chiamo «Dio». […] Dentro di me c’è una sorgente molto profonda. E in quella sorgente c’è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente essa è coperta di pietre e sabbia: allora Dio è sepolto. Allora bisogna dissotterrarlo di nuovo.”.
Scrive Etty: “Il misticismo deve fondarsi su un’onestà cristallina: quindi prima bisogna aver ridotto le cose alla loro nuda realtà”; in questo sembra essere un’anima più orientale che occidentale (del resto afferma: “…credo che un viaggio in Oriente lo farò, in futuro – per trovare in quei luoghi, vissute ogni giorno, quelle cose in cui qui ci si sente soli, in dissonanza”): per lei non esiste spiritualità che non parta dall’esperienza dell’hic et nunc, e la preghiera è una vera e propria pratica, a partire dall’atto stesso dell’inginocchiarsi – per Etty tutt’altro che scontato. Il Dio di Etty non è il Padre autoritario degli Ebrei, né quello misericordioso dei Cristiani; non è una figura lontana, oltre i cieli, ma è fatta di carne e sangue, è qui e ora, nel suo corpo: è il “cuore pensante” che Etty incarnerà nelle baracche di Westerbork e Auschwitz, fino alla fine della sua breve vita.
L’ascolto della parte più profonda del suo essere la trasforma: nel giro di due anni, Etty impara a riconoscere sempre più precisamente in sé e negli altri quel ‘luogo’ ricco e silenzioso, celato dal chiacchiericcio e dall’abitudine; scava dentro se stessa con onestà e coraggio, sottoponendosi a un’autoanalisi impietosa, riconoscendo le maschere con cui il suo ego si protegge e lasciandole a poco a poco cadere. Gradualmente prende coscienza del fatto che “non sono mai le circostanze esteriori, è sempre il sentimento interiore […] che dà a queste circostanze un’apparenza triste o minacciosa”: in altre parole, a farci soffrire sarebbero le nostre “idee stereotipate su questa vita” che formano il nostro ‘io’, “questo io tanto ristretto, coi suoi desideri che cercano solo la loro limitata soddisfazione [e che] va strappato via, va spento. […] Dobbiamo nel nostro intimo liberarci di tutto, di ogni idea esistente, parola d’ordine, sicurezza; dobbiamo avere il coraggio di abbandonare tutto, ogni norma e appiglio convenzionale, dobbiamo osare il gran salto nel cosmo, e allora, allora sì che la vita diventa infinitamente ricca e abbondante, anche nei suoi più profondi dolori.”.
Etty individua nella non accettazione della sofferenza la causa principale e più comune della sofferenza stessa: “L’uomo occidentale non accetta il ‘dolore’ come parte di questa vita: per questo non riesce mai a cavarne fuori delle forze positive.”. E ancora: “…l’uomo soffre soprattutto per la paura del dolore.”. L’unica soluzione, conclude, è aprire le braccia a ciò che normalmente si teme, forti della sola certezza di cui si disponga: il profondo rapporto con il proprio centro interiore, voce ed espressione del mistero che siamo. Si tratta di accettare qualunque prova la vita ci sottoponga – lo strazio del lutto come la gioia della condivisione, le persecuzioni dei nazisti come il sublime delle poesie di Rilke… Nel pieno del dolore più intenso, in occasione della morte di Spier (che Etty ha teneramente amato, ricambiata), scrive: “Mi metti davanti ai tuoi massimi enigmi, mio Dio. Ti sono riconoscente per questo, ho anche la forza di affrontarli, di sapere che non c’è risposta. Bisogna saper sopportare i tuoi misteri.”.
E’ con questo proposito che Etty decide di non mettersi in salvo da quella che lucidamente riconosce come la precisa volontà di sterminare il suo popolo; fuggire sarebbe perdere l’occasione di comprendere con la mente e col corpo il senso (anche etimologico) della parola ‘accettazione’, che porta in sé entrambi i significati di ‘dare’ e di ‘ricevere’. Tuttavia precisa: “la mia accettazione non è rassegnazione, o mancanza di volontà: c’è ancora spazio per l’elementare sdegno morale contro un regime che tratta così gli esseri umani. Ma le cose che ci accadono sono troppo grandi […] perché si possa reagire con un rancore e un’amarezza personali. Sarebbe una reazione così puerile, non proporzionata alla ‘fatalità’ di questi avvenimenti. […] E’ il senso dell’ineluttabile e la sua accettazione, la coscienza che in ultima istanza non ci possono togliere nulla.”. In quest’ottica l’aguzzino torna ad essere una persona, mossa da forze più interessanti che malvagie: “Rimane sempre il fatto che la vita è così ‘interessante’, in ogni circostanza. Provo un bisogno quasi diabolico di osservare ciò che capita.”; “Pensavo: com’è strano. C’è la guerra. Ci sono campi di concentramento…”; e riferendosi ad un sorvegliante ebreo del campo di smistamento di Westerbork: “…non ero risentita con lui, m’interessava troppo. In certi momenti mi faceva una pena terribile.”. Quando l’interesse prende il posto della condanna diventa possibile “ogni volta rintracciare il nudo, piccolo essere umano che spesso è diventato irriconoscibile. In mezzo alle rovine delle sue azioni insensate.”
Ovviamente, se da un lato la sua crescita interiore permette a Etty di comunicare col prossimo a livelli più profondi e di “contribuire a disseppellire [Dio] dai cuori devastati di altri uomini”, tuttavia l’autrice non tarda ad incontrare le incomprensioni e addirittura l’astio di chi, davanti al disastro che avanza, si aggrappa al proprio giudizio come un naufrago a un salvagente sgonfio: “Molte persone mi rimproverano per la mia indifferenza e passività e dicono che mi arrendo così, senza combattere. Dicono che chiunque possa sfuggire alle loro grinfie deve provare a farlo, che questo è un dovere, che devo far qualcosa per me. Ma questa somma non torna. […] Il buffo è che io non mi sento nelle loro grinfie, sia che io rimanga qui, sia che io venga deportata.”.
Spoglia di ogni illusione riguardo un aiuto dall’esterno, in attesa dell’ordine di partenza per Westerbork, Etty comincia a dire addio: giorno per giorno prende congedo dalle abitudini, dai piccoli piaceri della sua vita, dagli affetti più profondi; in una parola, comincia a “vivere per la morte”, che per lei non è più una minaccia, ma l’occasione per una coscienza di sé sempre più profonda e radicata: “Incomincerò a far ordine nelle mie carte e ogni giorno dirò addio. E così il vero addio sarà solo una piccola conferma esteriore di ciò che, di giorno in giorno, s’è già compiuto dentro di me.”. A Westerbork, come si legge negli scritti di alcuni suoi compagni di prigionia, saprà testimoniare la propria “fede” nel suo Dio interiore, ‘contagiando’ il prossimo con la forza incrollabile cui attinge nella sua ‘strana’ preghiera, sola con se stessa.
L’unica esperienza che l’autrice del diario ammette di temere è partire per Auschwitz insieme alla propria famiglia: assistere alla sofferenza e alla morte dei suoi cari è una prova che teme di non saper sopportare. Nemmeno questo compito le verrà risparmiato: partirà infatti coi genitori e uno dei suoi due fratelli un giorno di settembre del 1943, diretta al campo di concentramento in cui morirà due mesi più tardi. Tuttavia, leggendo nella lettera di un suo compagno di prigionia dell'”allegro ciaaao di Etty dal vagone n. 12″, c’è da credere che, in ultimo, sia stata piena di gratitudine anche per questa estrema possibilità di essere fedele al divino che aveva trovato in sé e negli altri – un divino che risplende nella consapevolezza che “dobbiamo accettare tutto dentro di noi, […] sapere che le «cose ultime» non possono esserci sottratte; allora, con quella pace interiore, sapremo ben compiere i passi necessari.”.




