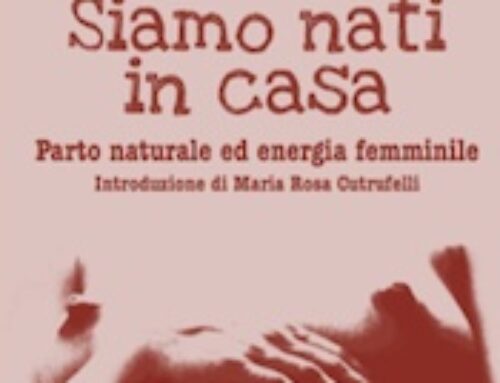Cosa è importante che una donna abbia capito prima di partorire?
Quando la data del parto si avvicina, inevitabilmente qualcosa all’interno della donna comincia a reagire, timore e fascino per ciò che sta per accadere si alternano. Tutte le donne vivono questo ma, fra quelle che praticano yoga non tutte reagiscono allo stesso modo: c’è chi, nelle ultime settimane, intensifica la pratica e chi smette completamente di venire a lezione senza alcun preavviso.
Sicuramente con l’avvicinarsi della data del parto qualcosa nella donna tira delle conclusioni:
Chi, nonostante le continue precisazioni da parte di chi insegna, ha visto nella pratica di yoga un benessere e nient’altro, probabilmente andrà alla ricerca di qualcuno che le dia “istruzioni” su cosa fare al momento del travaglio e del parto; istruzioni del tutto inutili in quanto il parto è un evento imprevedibile, non controllabile attraverso una tecnica. D’altronde accettare questo non è da tutte, richiede una forza che non sempre è presente, ed è importante che la donna si renda conto che, forse, lo yoga non è la sua via; anche capire di non riuscire a capire è una comprensione.
Chi invece intensifica la pratica, probabilmente ha colto qualcosa d’interessante, qualcosa in lei ha compreso anche se non sempre è in grado di dirsi cosa ha capito.
Quale comprensione è importante per le donne che continuano a praticare?
Credo sia necessario innanzi tutto avere chiaro che lo yoga non è una via salutistica, non garantisce una gravidanza senza problemi, né un parto facile. Il suo effetto è un “benessere” che non dipende dal fatto che tutto vada bene.
Per arrivare a questo la donna deve avere acquisito la capacità di guardarsi dentro, di ascoltarsi, di stare con se stessa di là dai turbamenti che ciò potrebbe comportare.
Da questo nasce la capacità di domandarsi su ciò che sente.
Cosa voglio veramente?
Cosa temo che accada?
Cosa temo che non accada?
Per soffermarsi su queste domande occorre avere colto, attraverso la meditazione, un centro, un luogo interiore, il soggetto che si pone le domande e che, ripiegandosi su se stesso, si risponde.
Non parlo di un luogo in cui credere, ma un’esperienza che ha il sapore dell’indubitabilità, che è una certezza.
Leboyer scrive che il parto è un mare in tempesta e che occorre una zattera per attraversarlo.
Questa certezza è la zattera.
Il parto è un’esperienza intensa che ha la capacità, in poche ore, di squarciare il velo illusorio di normalità che ricopre la nostra esistenza.
Uno dopo l’altro, i riferimenti sui quali la donna contava, vengono a mancare: non c’è più controllo, il corpo va da sé, mosso da una misteriosa potente energia, il tempo scorre in modo diverso, lento, quasi fermo; le persone più familiari paiono lontane, sconosciute. Michel Odent afferma che la donna “va su un altro pianeta” e che, se questo non accade, allora ci saranno problemi.
In questa dimensione si rivela il valore della pratica.
Per qualche ora, alla donna è data la possibilità, forse unica, di avvicinarsi al Mistero che lei stessa è, nella sua potenza e nel suo tremendo fascino; se anziché arretrare al principio di se stessa rimane in periferia, allora vive un dramma.
Non avere un centro in quei momenti trasforma un’esperienza che definirei mistica in un inferno: la donna confusa è in balìa dell’evento anziché abbandonata, lotta anziché rispettare, rifiuta, si chiude anziché aprirsi, è disperata anziché affascinata, sconfitta anziché arresa.
Se la donna ha praticato seriamente e molto in gravidanza, allora dovrà semplicemente continuare a farlo durante il travaglio e il parto.
Quando le contrazioni, divenendo regolari le “dicono” che il bambino ha iniziato il suo viaggio, la prima cosa da fare è, come in una sequenza, Shavasana.
Far silenzio, raccogliersi, lasciando che la gravità azzeri ogni tensione disturbante; entrare in contatto col respiro e col luogo da dove si osserva il respiro. Ad un certo punto le contrazioni, prendendo un ritmo più veloce, chiederanno di modificare shavasana: la donna riemerge quindi lentamente per darsi la possibilità di fermarsi o di cambiare la posizione in qualunque momento.
Ma ora non c’è, come nella pratica di gruppo, una sequenza di posizioni stabilita precedentemente: ora ci sono solo un sentire e un luogo da cui cogliere questo sentire.
Cogliere un sentire significa ascoltarlo chiedendosi cosa sta dicendo: forse ci dice che la posizione è da modificare e la pratica precedente di yoga l’ha educata a farlo lentamente, così da riuscire a fermarsi nel momento in cui sente di avere trovato la posizione più adatta, per non disturbare la contrazione.
La contrazione, infatti, va vista per quello che è, una profonda sapienza del corpo che permetterà al bambino di nascere; qualcosa di cui stupirsi, da rispettare piuttosto che da contrastare.
Nasce un ritmo che trascende la volontà ed il controllo, e anche il respiro entra in questa specie di danza travolgente. Come nella pratica guidata, anche qui il respiro va contemplato, mai giudicato, mai ostacolato. Tutto ciò che è umano, tensioni, resistenze, va spazzato via: qualcosa deve farsi da parte per far spazio ad Altro.
Non è facile e in aiuto può venire il canto, sottile confine tra volontario e involontario, che dice alla donna che lei c’è anche se, finalmente, non sa più cos’è.
Anche nel canto si rispetta un sentire: può esserci la necessità di cantare ad alta voce o di sussurrare appena, il tutto attingendo all’esperienza fatta nella pratica in gruppo.
Guidato da un’inspiegabile saggezza, al momento giusto, l’utero modifica i propri movimenti per permettere al bambino di uscire. Quest’affascinante momento viene di solito chiamato in modo orribile: “fase espulsiva”; dimenticando che si tratta della nascita di un nuovo bambino. La migliore definizione di questa fase l‘ho sentita da Bérnadette Pistre, un’insegnante di yoga francese: “Non è il bambino che è espulso ma è l’utero che, divenuto inutile, si ritira”.
In questi momenti meravigliosi e terribili allo stesso tempo, è indispensabile che la donna si raccolga, che ritorni al principio, testimone stupita che attende di incontrare il primo sguardo del bambino, grata di avere intrapreso una via che le abbia permesso quest’esperienza di cui, poi, dovrà trovare il significato.