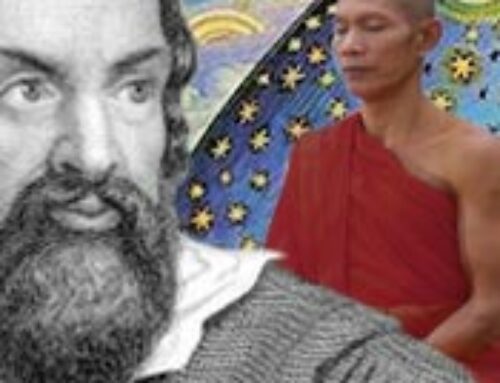Dal 16 al 23 luglio 2016 presso la Casa delle associazioni Peter Mayr di Longomoso, sull’altopiano del Renon (BZ).
Un percorso per esplorare più a fondo la non sempre chiara figura del Maestro della Foresta Nera
Introduzione
Martin Heidegger, nonostante le severe critiche a cui è soggetto periodicamente, resta il filosofo del ‘900 per eccellenza col quale pressoché tutti gli altri continuano ancora misurarsi. Ciò accade per i radicali temi da lui affrontati: la rifondazione dell’indagine dell’esperienza umana proposta in Essere e Tempo, i temi dell’oblio dell’essere, della gettatezza, della Differenza ontologica, della “fine della filosofia” e infine per la questione della Tecnica di cui profetizzò il dominio totalizzante oggi sotto gli occhi di tutti. Egli ci lasciò a confrontarci con la domanda fondamentale circa il senso dell’essere. Non ultima ragione dell’interesse che Heidegger continua a suscitare sono le recenti uscite dei Quaderni Neri, evento che ha coinvolto recentemente i media di tutto il mondo.
Che filosofo e che uomo fu Martin Heidegger?
Fu davvero fenomenologo?
Fu esistenzialista, filosofo del niente, come lo definì qualche detrattore?
Fu nazista?

Il professor Alfredo Marini, brillante docente e traduttore per Mondadori di Essere e Tempo, grande e profondo conoscitore di Heidegger, proporrà un percorso per esplorare più a fondo la non sempre chiara figura del Maestro della Foresta Nera.
Scheda biografica
Alfredo Marini si è laureato in filosofia teoretica con Enzo Paci a Pavia, dove è stato a lungo assistente volontario alle cattedre di filosofia morale e filosofia teoretica. Dal 1961 al 1964 ha vissuto in Germania dove ha studiato sugli inediti degli Archivi Husserl di Friburgo, Colonia e Lovanio le origini del metodo fenomenologico. Dal 1980 è professore associato presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2007 opera presso la Società Umanitaria di Milano dove dirige un corso annuale di “Filosofia e Vita Quotidiana”. Ha tradotto e curato l’edizione italiana di Essere e Tempo pubblicata nel 2006 da Mondadori nella collana I Meridiani.
Presentazione del corso
Martin Heidegger (Messkirch 1889 – Freiburg i.Br. 1976), come filosofo e teorico, ha due parole-chiave: “ESSERE” e “PENSIERO”. La formula del loro rapporto è la DOMANDA CIRCA IL “SENSO” DELL’ESSERE COME TALE. Heidegger non usa il linguaggio per esprimere pensieri ma, come i poeti, pensa e nuota nel linguaggio come parola natante, come una medusa nell’acqua: vi nasce, la usa e ne dipende interamente. Il suo libro più rivelatore su questo punto è Cosa significa pensare? ed. Sugarco
Come personaggio storico, Heid. passa per il pensatore-chiave della “Scuola fenomenologica friburghese”, che fa capo all’ultima fase della lunga carriera di Edmund Husserl (1859-1938). Una scuola filosofica di stile al 100% “accademico”, ma che, dai primi del ‘900, ha cominciato a interessare tutti i settori della cultura internazionale. Gli esponenti ne sono: Edmund Husserl, Martin Heidegger, Eugen Fink e, infine, Friedrich-Wilhelm von Herrmann.
Il quale dagli anni ’60 cura la Gesamtausgabe di Heidegger per l’editore di Francoforte Vittorio Klostermann. Vastissima la schiera dei discepoli, continuatori, imitatori, interpreti, studiosi.
 Heidegger è diventato non ha dovuto attendere scadenze e anniversari per essere frequentato e celebrato, ma anche invidiato e calunniato. In patria e all’estero; tra i filosofi e i non-filosofi, a cominciare dal 1916/17.
Heidegger è diventato non ha dovuto attendere scadenze e anniversari per essere frequentato e celebrato, ma anche invidiato e calunniato. In patria e all’estero; tra i filosofi e i non-filosofi, a cominciare dal 1916/17.
- Il fatto di esser diventato famoso in Germania prima di aver scritto qualcosa, perché associato alla fama di Husserl, ha fatto di lui “un fenomenologo“. (vedremo cosa vuol dire)
- Il fatto di esser stato nominato Rettore dell’Università di Friburgo (maggio 1933) dal suo ultimo Senato accademico autonomo (mentre Hitler è da poco presidente del consiglio della Repubblica di Weimar e, di lì a pochi mesi, diventa anche capo dello Stato) ha fatto di lui “un nazista”. (vedremo cosa vuol dire)
- Il fatto di essere nato cattolico e di aver aspirato fin da ragazzo al sacerdozio nell’ordine dei Gesuiti (ma la sua domanda fu respinta dall’Ordine) – finì per farne, almeno presso i cattolici badensi, “un apostata“ o “un traditore“ (vedremo come). Il libro più documentato in proposito è quello dell’economista cattolico friburghese Hugo Ott, Sentieri biografici, ed. Sugarco
- Il fatto di aver lasciato spezzata e non conclusa la splendida architettura del suo capolavoro filosofico “Essere e tempo“ e di aver dichiarato (come Hegel) la fine della filosofia ma – contrariamente a Hegel –, non per essersi “realizzata” in un sistema, ma per essere “autenticamente fallita“ – ha fatto di lui “un mistico“ o “un irrazionalista”. Vedremo cosa vuol dire, ma diciamo subito che questa era soltanto la forma originale in cui Heidegger prendeva congedo dalla “metafisica” (e non da un presunto “esistenzialismo”). Il che significava per lui poter porre nuovamente il problema dell’essere come tale da parte di un Esserci umano (Dasein), inteso come “projetto-dejetto”.
Da questa sua personale svolta, che sprofonda nella metafisica per superarla, cominciava per Heidegger una nuova, inversa, “obbedienza” del pensiero (Denken), che è appunto la sequela di tale rovescio della metafisica (la Kehre), già implicito nella dinamica propria della metafisica stessa e nel suo linguaggio.
Mentre prima il problema del senso dell’essere si riferiva dell’essere dell’Esserci (cioè alla cura) – e la filosofia ne cercava il senso nella temporalità (come avevano indicato Dilthey e Husserl!) –, d’ora in poi il pensiero cerca di mettere a nudo (erörten) le radici, o le condizioni di possibilità (il contesto) non di ogni “conoscenza” della temporalità, ma di ogni temporalizzazione; e il filo conduttore ne è la temporizzazione (e vedemo che cosa vuol dire!).
La temporizzazione (Zeitigung) è il venire incontro, l’emergere, l’insorgere, il presentarsi-depresentarsi dell’ente (cosa-occasione-kairòs: dal boccale di birra alla storia del mondo). La dimensione di questa esperienza non è più la dialettica della storia e dell’anima; non sapere del pensiero calcolante (tecnico-scientifico, ipotetico-deduttivo statistico-descrittivo) della scienze moderne e della loro virtuale capacità di gestione della cura; non la conoscenza criticamente purificata di Kant; non l’intuizione eidetica di Husserl – ma si rivolge solo alla comprensione e all’interpretazione dell’essere e incorpora anche il “senso d’essere” della sensazione, della percezione, del sentimento, dell’impegno, della prassi e insomma della storia dell’essere (ontostoria: intesa non come ricerca o racconto dell’accaduto, ma come accadere tout court). (e vedremo cosa vuol dire in rapporto a Nietzsche)
Discutendo questi “fatti” e spiegando questa dozzina di “parole” cercheremo di capire cosa intenda Heidegger quando dice “ESSERE” e quando dice “PENSIERO”.
Orari delle lezioni
- Sabato 16 luglio: presentazione del corso alle ore 21
- Da domenica 17 luglio a venerdì 22 luglio:
- Mattino: dalle 10 alle 12
- Pomeriggio: dalle 17 alle 19
- Il corso si concluderà con la lezione del mattino di sabato 23 luglio.
- È prevista una mezza giornata libera che verrà decisa in base alle condizioni metereologiche.
Programma del corso
La filosofia di Heidegger non è la proposta di una formula metafisica come invece accade in tutta la tradizione della filosofia occidentale: il suo pensiero non gira attorno a un concetto-chiave che ci apra lo scrigno del mondo e ne interpreti i segreti.
In altri termini: non ci offre nulla che si possa porre sullo stesso piano:
- delle idee platoniche,
- dell’ousia (essenza, o sostanza) aristotelica,
- della pronoia stoica (destino, o provvidenza) o dell’eimarmenē gnostica,
- dell’epica narrazione neoplatonica, che parte dall’Uno, si disperde nel mondo e torna all’uno (hen, proodos, epistrophē).
Inoltre, benché Heidegger sia fin dai suoi primi studi legatissimo alla “concezione cristiana della vita”, non condivide la
– concezione onto-teo-logica del Dio giudaico-cristiano come Creatore del mondo e la concezione medievale del mondo come “il Creato” (incorporata nei dogmi cattolici fin dai primi secoli dell’era volgare). La “teologia greca” è per Heidegger un evento che storicamente accade alla fede cristiana e che andrebbe sottoposto a una critica deontologizzante del genere di quella (“demitologizzante”), alla quale il suo amico marburghese Rudolf Bultmann andava sottoponendo la mitologia cristiana.
E neppure apprezzava:
– la dottrina tomista della analogia entis (che considerava un astuto espediente per non decidere sulla questione teoretica pura e fondamentale: cioè, tra il senso univoco e il senso equivoco dell’essere come tale, in rapporto al nesso tra l’essere divino e l’essere umano). Heidegger combatté per tutta la vita l’interpretazione “tomista” di Aristotele.
Anche la metafisica moderna – benché da Cartesio in su si affianchi al trionfo della sperimentazione galileiana, dell’analisi e della matematizzazione del sapere scientifico – produce una serie di proposte tipicamente “metafisiche” come
– il cogito, il dubbio metodico, la dottrina delle due sostanze e della veracitas divina
– la trasformazione spinoziana delle due sostanze in due attributi dell’unica sostanza divina
e una serie di altre formulazioni fino alla
– rivoluzionria Critica kantiana della metafisica che, dai successori immediati di Kant (gli idealisti tedeschi) viene interpretata in senso trascendentalista.
Da questa linea idealista e trascendentalista, e parallelamente dalla linea post-cartesiana anglosassone del cosiddetto “empirismo inglese” abbiamo ancora nell’800 le più clamorose proposte metafisiche moderne:
– quella hegeliana della dialettica dell’Idea con tutta una serie di seguiti e variazioni tra cui il marxismo e l’idealismo italiano. E
– quella positivista di Auguste Comte e J.St. Mill che in forme assai variate attraversano tutto l’Ottocento e il Novecento affiancando alla fioritura scientifica delle scienze naturali quella delle scienze umane.
In effetti, la filosofia di Heidegger o, meglio, la sua riflessione sulla storia e l’attualità della filosofia, ha un legame ben preciso con la determinatezza storica delle sue origini: non cade dal cielo ma nasce in riferimento a una linea di psicologia neotomista di Franz Brentano e una linea di filosofia fenomenologica di Edmund Husserl, in un periodo segnato dalla generale crisi del positivismo, dalle filosofie neocriticiste ispirate al “ritorno a Kant” e dalle riflessioni di filosofi e scienziati sulla crisi dei fondamenti delle scienze europee. Ma Heidegger dichiara di non avere “una propria filosofia”, anzi dichiara che la filosofia stessa è finita e che il suo posto è ormai occupato dalla cibernetica. Non si può negare che il lavoro di Heidegger sulla tradizione filosofica è un lavoro di esegesi e interpretazione. Il fascino del suo lavoro, quali che ne siano le motivazioni vissute, sta nel modo nuovo in cui rilegge, e ci fa rileggere, i classici.
Assistente di Husserl dal 1915, già dall’anno successivo al suo primo seminario universitario, all’ombra del grande fondatore della fenomenologia cominciò a definirsi la sua personalità di docente e di filosofo e la sua fama come assistente di Husserl a diffondersi rapidamente nell’ambiene universitario tedesco. L’opera di Heidegger è un magistero di ermeneutica filosofica. Dall’esempio di Husserl Heidegger ritrae lo spirito di ricerca: storicamente il motto della fenomenologia era stato “alle cose stesse!”. Il suo senso immediato era di non curarsi delle opinioni correnti, della tradizione e delle risposta già fatte, ma di vivere direttamente il rapporto con i problemi e con le domande attuali. In realtà, fino agli anni ’30, nonostante la presunzione (“husserliana”) del filosofo teoretico che si ritiene l’unico critico e giudice di se stesso, lamentando paradossalmente l’insufficiente radicalità della sua propria critica della “vita teoretica”, Heidegger fu vittima delle passioni dei sentimenti delle motivazioni culturali che modulavano e straziavano il suo mondo e che lo colpirono senza pietà. Resta da vedere se fu più interessante e ricco di scoperte il suo modo di vedere il mondo prima della svolta o dopo la svolta, quando accettò la sconfitta (“fallì autenticamente”) e provò a vedere il mondo “dal di fuori”!
Quadro delle lezioni
- Lez. Introduttiva (sera d’arrivo, sabato 16 luglio) Illustrazione sommaria del corso in dodici lezioni: “Carattere unitario della ricerca heideggeriana e sua articolazione storica e sistematica”. Le fasi della sua ricerca nei momenti storico-biografici salienti e il problema centrale (il “pensiero incessante” dell’essere).
- 1ª Lez. La Chiesa. La fede cattolica e la tradizione aristotelico-tomista. Fare come S. Tommaso, ma non come i neo-tomisti. Franz Brentano e Carl Braig: il problema dell’essere. I “nuovi maestri” (neokantiani, la “nuova scuola”): Lotze, Rickert, Natorp. Dissertazione di Laurea (1911: psicologia e il giudizio) e Tesi di docenza (1916: dottrina delle categorie, il giudizio e l’io trascendentali). L’eterotesi di Rickert e la sovraopposizionalità di Emil Lask.
- 2ª Lez. L’Università. Problemi di esistenza tra carriera universitaria e vocazione sacerdotale (scuole e studi, Brandhuber e Gröber; borse di studio. Prospettive universitarie: i diari di Ernst Laslowski e di Engelhard Krebs). Il “Curriculum” (1915 per la docenza)
- 3.ª Lez. La nuova formazione filosofica: La “psicologia descrittiva” (Brentano – Dilthey – Husserl). L’incontro con Husserl (1916: primi seminari di Heid., il “giardino d’infanzia fenomenologico” e inizio della sua fama) e lo studio di Dilthey (corso di Husserl sulla psicologia di Dilthey, “pesanti” letture di Heid.; intenzioni di Dilthey e posizione di Yorck).
- 4ª Lez. Nuovo programma (“mein Aristotelesbuch”) nei primi corsi friburghesi dal 1918 al 1923 (inizialmente, esclusi dalla GA!).
- 5ª Lez. Incarico d’insegnamento a Marburgo 1924-27 e maturazione del piano di SuZ. Tutti corsi direttamente o indirettamente su Aristotele.
- 6ª-7ª Lez. Genesi del piano di Essere e tempo e sua struttura
- 8ª Il Partito. Lez. Rektoratsrede (1933) +Introduzione alla metafisica (1935). La svolta (Wende) e il rovescio (Kehre)
- 9ª Lez. M. Heidegger/ Anna Arendt/ K. Jaspers (dalla visita di K.J. a Friburgo alla relazione con la Arendt, la parentesi del Rettorato, il letargo durante il regime e il rapporto con “gli alleati”. Il ritorno della Arendt a Friburgo nel dopoguerra.
- 10ª Heidegger-Jünger. Ernst Jünger, Der Arbeiter [* Über die Linie]. Dal seminario su Der Arbeiter al saggio Oltre la linea.
- 11ª-12ª “Ontostoria”: Contributi alla filosofia & I quaderni neri.